|
 LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA
LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA
I POZZI
FETENTI
(Puzzu Fitenti)
Nel cuore dell’attuale
rione Commenda vi era un’area che per oltre un
millennio ha preso il nome di Pozzi Fetenti
per via di alcune cavità che emanavano
esalazioni particolarmente sgradevoli.
La zona dove erano ubicati questi pozzi, secondo l’opinione
di alcuni storici locali e confermata degli anziani
brindisini che ricordano l’area nell’immediato
secondo dopoguerra, era racchiusa nel quadrilatero compreso
tra le attuali via Appia, via Orazio Flacco, via Mecenate
e via Numa Pompilio, una denominazione che trova riscontro
in un antico documento del 1260 dove la località
era già indicata come “Puteus
fetens”.

Brindisi, via Orazio Flacco
angolo via Giulio Cesare. A sx sorgevano le casupole
conosciute come Puzzu Fitenti
L’origine
del nome deriverebbe da un tragico e violento
avvenimento risalente al 1070, durante il dominio
bizantino. La città era ancora pressoché
disabitata e solo grazie ai greci stava iniziando
a rinascere dallo stato di desolazione nel quale
era stata lasciata per ben due secoli dopo la
distruzione longobarda e le prime incursioni
saracene. Brindisi perciò non poteva
offrire un reclutamento militare locale di supporto
alle milizie bizantine per la difesa del luogo.
I normanni infatti, che avevano già occupato
la città dal 1062 al 1067, in più
occasioni avevano tentato - invano - la riconquista,
la battaglia più cruenta si ebbe nel
1069 quando le truppe di Roberto d'Altavilla
detto il Guiscardo
(l’Astuto) e del conte Goffredo
furono respinte “sia per parte di
terra che per parte di mare” procurando
un elevato numero di vittime.
Dopo questo tentativo la città fu posta
sotto il comando del duca di Skopje, il generale
Nikephoros Karantenos, che
però temeva - a ragion veduta - nuove
incursioni da parte dei normanni. Lo strategos
bizantino vedeva aumentare ogni giorno il numero
dei nemici e non potendo contare su una milizia
sufficiente a respingere l’imminente attacco,
sperava nei rinforzi chiesti all’imperatore
Romano IV, che però
tardavano ad arrivare. Nel timore di perdere
la propria reputazione con la fuga, che pareva
essere l’unica via di uscita dalla delicata
situazione, decise di rimanere sul posto e pianificò
un inganno: fece negoziare fintamente la consegna
della città ai nemici che caddero nel
tranello. Il giorno convenuto nel gennaio del
1070, una schiera di soldati e di scudieri normanni
giunse senza ostacoli presso le mura della città
ma non appena le scalarono furono uno dopo l’altro
catturati ed uccisi, “forse 83 o 100
in tutto, e le loro teste tagliate furono portate
prima a Durazzo e infine inviate all'imperatore
nella capitale”. I cadaveri decapitati
furono invece gettati nei pozzi situati oltre
le mura della città, che esalarono per
lungo tempo il fetore dei corpi in decomposizione.

Rievocazione della battaglia
dell’XI secolo fra Normanni e Bizantini (ph. Emanuele
Franco ®)
Il primo a collegare
l’episodio con il luogo “ubicabile fuori
la porta di Mesagne” denominato “Pozzi
Fetenti” fu nel XVI sec. lo storiografo Giovan
Battista Casimiro, seguito nei secoli successivi
da altri autori e storici locali, talvolta con differenti
considerazioni sulla figura del generale bizantino,
definito “vile, traditore e odiato dai cittadini”
per aver ricorso all’ignobile trappola, mentre
secondo altre fonti sarebbero stati i normanni ad accordarsi
con alcuni assediati per consentire il loro ingresso
dentro le mura, ma “o che i traditori facessero
il doppio gioco o che fossero scoperti, la sorpresa
non si verificò”.
Sta di fatto che l’inganno servì solo a
ritardare la conquista normanna che avverrà nel
1071.

Rievocazione della battaglia
dell’XI secolo fra Normanni e Bizantini (ph. Emanuele
Franco ®)
In questi ultimi
anni è stata prospettata una nuova ipotesi sull’origine
del toponimo che potrebbe derivare dalla presenza di
acque sulfuree nei pozzi in questione, ovvero caratterizzate
da una ricca presenza di solfuro di idrogeno e quindi
dal tipico odore fetido. Denominazioni dello stesso
tipo trovano riscontro nelle “acque utilizzate
a scopo terapeutico quali il pozzo salso di Massafra,
le ‘acque ferrate’ di Soleto e quelle ‘amare’
di Galatone” (G. Carito, 2013) ed ancora
la sorgente “Fetida” di Santa Cesarea Terme.
La zona ha
mantenuto l’appellativo di “Puzzu
Fitenti” (stavolta al singolare) sino
agli anni ’60, gli agricoltori più anziani
ricordano l’area particolarmente degradata, con
ristagni di acque piovane e di lavorazione dei vicini
stabilimenti vinicoli, dove il cattivo odore era pressoché
costante; c’è chi ricorda un ampio cortile
tra casette minime situato alla spalle del carcere giudiziario
e più precisamente al vertice tra via Orazio
Flacco e via Giulio Cesare, dove sembra vi fosse un
pozzo particolarmente antico.
Altre fonti indicano la zona estesa oltre l'attuale
via Appia, a comprendere una parte ricadente nel rione
Cappuccini, tra via Montegrappa e via Fulvia. In tutte
queste zone le casupole esistenti prima del loro abbattimento
(quelle del rione Cappuccini tra gli anni '60 e '80,
quelle del rione Commenda dopo il 2000) per lasciare
il posto a nuove costruzioni, erano con i tetti coperti
da embrici e privi diservizi igienici, con pavimenti
ricoperti da lastre calcaree.

Brindisi, via Orazio Flacco
angolo via Giulio Cesare. Le casupole conosciute come
Puzzu Fitenti (ph. G.Catanzaro)
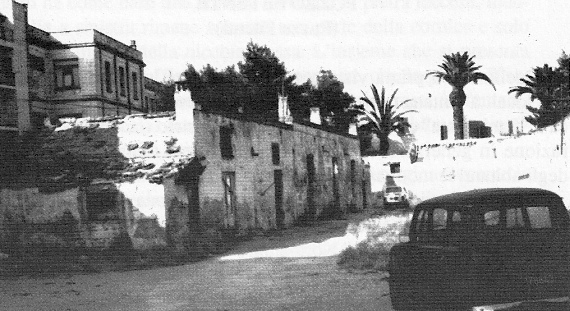
Brindisi, via Montegrappa.
Le casupole conosciute come Puzzu Fitenti (ph.
G.Catanzaro)
Con l’urbanizzazione
del quartiere il nome è scomparso dall’uso
comune, restando solo nel ricordi degli ultimi che lo
hanno conosciuto.
Si ringrazia il
fotografo Emanuele Franco per aver fornito e concesso
l'uso delle immagini recenti
|
Bibliografia:
- Giacomo Carito,
Brindisi nell’XI secolo:
da espressione geografica a civitas
restituta, in L’età
normanna in Puglia. Aspetti
storiografici e artistici dell’area
brindisina. 2013
- Giuseppe
M.Catanzaro. Il quartiere Cappuccini
di Brindisi. 1997
|
|
Documenti correlati
- L'epica
battaglia tra normanni e bizantini del
maggio 1156 |
|
|

 è
un'idea di Giovanni Membola
è
un'idea di Giovanni Membola