|
 LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA
LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA
L'INCIDENTE
AEREO DEL 9 LUGLIO 1962
Un DC4 si inabissò in mare subito dopo il decollo
per una anomalia tecnica. E’ stato l’incidente
più grave avvenuto nei pressi dell’aeroporto
di Brindisi, morirono tutti i sei componenti dell’equipaggio
Il 9 luglio del 1962
è la data che coincide con il disastro aereo
con il più alto numero di vittime mai accaduto
a Brindisi. E’ stato anche l’unico incidente
classificato come grave avvenuto nei pressi della nostra
aerostazione, un tragico evento che, dopo l’attenta
valutazione dei rischi associati, ha determinato importanti
provvedimenti per la pianificazione e messa in atto
di misure di mitigazione dei pericoli alla popolazione.
Periodo drammatico per l’aviazione quel luglio
di quell'anno: due giorni prima, per un errore di navigazione,
un Douglas DC-8 dell’Alitalia era precipitato sulle
colline nei pressi di Mumbay (India), nessun superstite
tra i 9 membri dell'equipaggio e gli 85 passeggeri.
Il 6 luglio era caduto un aereo di linea sovietico causando
la morte di 14 persone. Qualche mese dopo, esattamente
il 27 ottobre, in un altro incidente aereo morì
Enrico Mattei, politico e fondatore dell’Eni, insieme
ad altre due persone. Le cause di questa controversa
tragedia sono rimaste avvolte nel mistero.

DC4 della Trans Mediterranean
Airways S.A.L. simile a quello precipitato a Brindisi
nel luglio del 1962
(ph. Angus Squire - autorizzata dall'Autore)
Breve storia
dell’aeroscalo
L’Aeroporto del Salento di Brindisi, denominazione
assunta nel 2010, in precedenza era intitolato ad Antonio
Papola, in memoria del comandante di aeromobile civile
deceduto nel febbraio del 1938, un pilota che aveva
uno stretto legame con la città e che spesso,
anche fuori servizio, soggiornava presso l’Albergo
Orientale di Corso Garibaldi. A esso veniva associato
il nome Casale, la contrada dov’è situato
l'aeroscalo.
Nel suo libro pubblicato nel 1993, Francesco Gorgoni
racconta la storia e le origini dell’aeroporto,
partendo dalla stazione provvisoria per idrovolanti
voluta nel 1916 dalla Regia Marina Militare, un primo
nucleo stabile ed efficiente per fermare la minaccia
dell'aviazione austriaca di base a Durazzo. Da qui partì
il primo volo commerciale internazionale di linea italiana
che aprì al traffico la linea Brindisi-Atene-Istanbul,
sulla stessa direttrice si innestarono anche le linee
per Rodi, Venezia, Valona, Roma-Bari-Brindisi-Tirana-Salonicco,
Brindisi-Durazzo-Lagosta-Zara-Lussino-Pola-Trieste.
L’aeroporto terrestre entrò in funzione
il 30 luglio del 1933 dopo l’inaugurazione avvenuta
alla presenza di Benito Mussolini, i lavori furono comunque
completati nel 1937, quando divenne un importante scalo
idro-terrestre.
Durante il secondo conflitto mondiale furono realizzate
nuove piste ma l'attività civile si concluse
nel settembre del '43. Nel dopoguerra fu decretata la
separazione dei due settori e dopo le dovute modifiche
e la realizzazione del piazzale aeromobili, nel 1960
la nuova aerostazione venne aperta al traffico regolare.
Da allora l’aeroporto è stato più
volte rinnovato e ampliato, sostanziali modifiche sono
avvenute in particolare nel 2007 e nel 2018. Nel tempo
il traffico passeggeri ha sempre registrato un trend
di crescita costante, grazie anche alla presenza delle
compagnie low-cost.
Dalla metà degli anni Novanta le aree di decollo
vengono utilizzate dai voli umanitari gestiti dalle
Nazioni Unite (UNHRD e WFP), che qui hanno una base
logistica di pronto intervento umanitario e di supporto
delle operazioni di pace.
(per approfondire le origini
dell'aerroporo di Brindisi, clicca
qui)

Esterno dell'aeroporto di Brindisi
"Papola Casale" 1993 (ph. M. Frigione)

Aerostazione civile nel 1980
(ph. F. Gorgoni)
L’incidente
Lunedì 9 luglio del 1962 il volo commerciale
TMA 104, un Douglas DC-4 Skymaster OD-AEC della Trans
Mediterranean Airways S.A.L., sul quale viaggiavano
sei membri dell’equipaggio e un carico regolare
di 8.997 kg di merci varie, era partito da Londra alle
ore 12:02 per fare ritorno a Beirut con scali pianificati
a Francoforte e Brindisi. Il velivolo della pionieristica
compagnia aerea libanese fondata nel 1953, operava regolarmente
per il servizio di trasporto prodotti che collegava
Beirut con gli alcuni aeroporti europei via Brindisi.
La TMA è stata la prima società cargo
e di maggior successo dell’intero Medio Oriente,
almeno fino a quando il conflitto non prese il sopravvento.
Nel maggio del 1954 aveva acquisito il primo dei due
Douglas DC-4, i monoplani ad ala bassa che insieme ad
altri sei velivoli DC-6 facevano parte dell’intera
flotta dell’epoca. Un paio di questi velivoli furono
poi distrutti nel dicembre del ‘68 durante un attacco
da parte di un commando israeliano all'aeroporto di
Beirut, una rappresaglia dopo il dirottamento di un
volo da parte del gruppo del Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina.
Puntuale alle ore 21,28 l’aeromobile era atterrato
sulla pista dell’aeroporto di Brindisi. La sosta
era programmata dal piano di volo per completare il
rifornimento di carburante prima di attraversare il
Meditarreneo e giungere all’aeroporto internazionale
della capitale libanese. Quella sera le condizioni meteorologiche
generali erano buone, il cielo era sereno, con visibilità
di 15 km e totale assenza di vento. Completate le operazioni
di approvvigionamento dei 4.720 litri di benzina e 20
litri di olio per aeromobili W100 al motore n.4, alle
ore 22.41 il velivolo libanese decollò regolarmente
dalla pista numero cinque. Ma dopo circa un minuto,
quando si era sollevato a 90-100 metri dal suolo, il
DC4 precipitò in mare a poco più di due
chilometri e duecento metri dalla costa, a 4 gradi a
sinistra lungo il prolungamento dell’asse della
pista, non lontano da dove poi sorgerà la diga
di Punta Riso.
L’impatto con la superficie del mare generò
una forte fiammata seguita da una potente detonazione,
il fuoco fu lungamente alimentato dalla grande quantità
di carburante appena caricato. Alcuni testimoni riferirono
di una vampata sprigionata da uno dei motori già
prima che questo precipitasse in mare, altri dichiararono
di aver visto l’aereo non riuscire a guadagnare
quota, per poi iniziare a scendere assumendo una inclinazione
verso sinistra prima della sbattere con l’ala sul
mare, quindi rialzarsi appena e ricadere pesantemente,
esplodendo. Subito dopo l’aereo si inabissò
a una profondità di 55 metri, dove giace distrutto.

Il luogo dell'impatto (ricostruzione da Google Map)
Il boato scosse la pace degli abitanti del vicino Forte
a Mare e Castello Alfonsino, spaventati dall’accaduto
osservarono sgomenti la rossa fiammata che squarciava
la notte. I resoconti giornalistici riportarono tutti
l’inquietante bagliore determinato dalla deflagrazione
e dalle fiamme dei rottami galleggianti, rimaste attive
per circa un’ora e “distintamente visibili”
perfino dalle banchine del porto.
A seguito dell’allarme diramato dalla torre di
controllo, alcune unità della Marina Militare
insieme ai rimorchiatori Ardimentoso e Vigor, a due
vedette della Guardia di Finanza, un motoscafo della
Polizia e le motopompe dei Vigili del fuoco si portarono
immediatamente sul luogo del disastro per trarre in
salvo eventuali superstiti. Sulla zona si recarono anche
due navi di passaggio.
Non si salvò nessuno dei sei membri dell'equipaggio:
insieme al comandante Martin Rose, di nazionalità
sudafricana, morirono il secondo pilota Mitri, il radiotelegrafista
Amer e gli aviatori Halvany e Nakleh, tutti di nazionalità
libanese. L’unico cadavere recuperato fu quello
del sesto componente dell’equipaggio, l’australiano
Smith, il suo orologio da polso segnava le ore 00.18.
Il corpo orribilmente sfigurato fu riportato a terra
dal natante dei Vigili del Fuoco per essere consegnato
all’autorità giudiziaria.
Le operazioni di ricerca furono sospese qualche minuto
dopo l’una di notte su ordine del comandante della
Capitaneria di Porto, il tenente colonnello Belardini,
che dispose il rientro di tutti i mezzi navali. Ripresero
senza esito all’alba del giorno successivo. Immediatamente
dopo l’incidente, dall’autobotte Shell furono
prelevati alcuni campioni del carburante con cui era
stato effettuato il rifornimento nei quattro serbatoi
del DC-4, l’esito delle analisi non evidenziò
anomalie.

DC4 della Trans Mediterranean
Airways S.A.L. simile a quello precipitato a Brindisi
nel luglio del 1962
(ph. Ian MacFarlane, autorizzata dalla famiglia MacFarlane)
Le conseguenze
Nel report conclusivo dell’indagine fu indicata
come probabile causa dell’incidente una anomalia
tecnica dovuta alla diminuzione di potenza dei motori
n. 1 e 2 dopo il decollo, che determinò una graduale
perdita di quota. Secondo la commissione d’inchiesta
la possibile lenta reazione psicofisica dell'equipaggio,
dovuta alla stanchezza, avrebbe impedito la percezione
del pericolo e l'esecuzione tempestiva delle manovre
per prevenire l'incidente o a minimizzarne le conseguenze.
In realtà la manovra che avrebbe determinato
la leggera virata a sinistra del velivolo poco prima
dell’impatto, come indicato dai testimoni oculari,
potrebbe essere stata voluta dal comandante che, rendendosi
conto del pericolo, decise di allontanarsi il più
possibile dall’isola di Sant’Andrea che in
quegli anni era abitata da civili e militari della Marina
Italiana.
Oltretutto negli ampi magazzini alla base del Forte
venivano custoditi numerosi ordigni esplosivi, come
mine, siluri e proiettili dei cannoni installati nelle
vicine batterie militari, ancora funzionanti per le
ordinarie esercitazioni. Secondo quanto indicato da
alcuni abitanti dell’area militare, l’episodio
originò una serie di interrogativi e tanta preoccupazione
anche nell’opinione pubblica. E proprio da questo
scampato pericolo sarebbe scaturita la decisione delle
autorità militari e civili di liberare la pericolosa
polveriera non lontana dal centro abitato, e trasferire
tutto il materiale esplosivo in una area militare più
adatta e sicura, lontana dalla direzione di decollo
e atterraggio degli aerei. Nei mesi successivi, infatti,
con numerosi viaggi di una nave militare, tutti gli
ordigni furono trasferiti nei depositi dell’Arsenale
di Ancona.
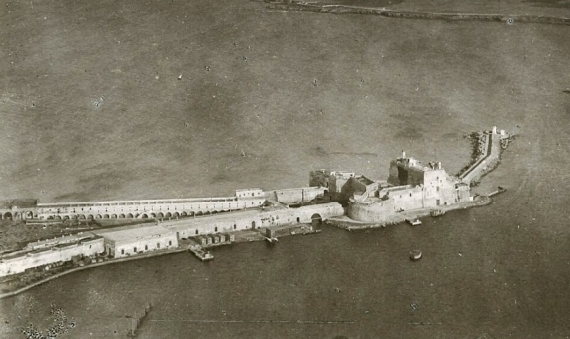
Il Castello Alfonsino e Forte
a Mare quando era ancora una polveriera
Giovanni Membola
per Il 7 Magazine n.400 del 25/04/2025
|

 è
un'idea di Giovanni Membola
è
un'idea di Giovanni Membola